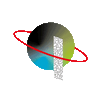Ritratto di trentenne in veste di scrittore
Da quando ho pubblicato dei libri le persone pensano che io sia uno scrittore. Eppure, seppure io scriva con impegno e con piacere, fatico a sentirmi tale. Ma cosa significa, davvero, essere uno scrittore? E come si convive con lo stigma della scrittura?

È passato quasi un mese da quando Su Facebook ha compiuto un anno di vita. Mentre sono ormai quasi due mesi che Stupidi Giocattoli di Legno è arrivato nelle librerie. Chi mi segue sul blog o sui social network lo sa o almeno dovrebbe saperlo, visto che di questi due libri parlo abbastanza spesso.
Ora accade che, specialmente dopo l'uscita di Stupidi Giocattoli di Legno, forse perché un libro di carta sembra più reale di un ebook, la gente ha cominciato a darmi dello scrittore. E la cosa, lo confesso, mi causa un certo grado d'imbarazzo da cui difficilmente riesco a uscire con argomentazioni convincenti.
Perché quando qualcuno, che non conosce dall'interno le dinamiche del mondo editoriale, ti dà dello scrittore sembra sempre attribuirti una sorta statuto altro, magico, auratico. Come se il fatto di aver pubblicato un libro ti rendesse diverso non solo da lui ma anche diverso dalla persona che eri fino a quel momento, e che continui a essere.
Il che è comprensibile, perché nella nostra cultura la parola "scrittore" non indica soltanto chi scrive, per passione o per lavoro, ma in senso più ampio chi con la scrittura ottiene una sorta di successo, per quanto effimero, che è, appunto, la pubblicazione. Ovvero il diventare "pubblico", e perciò visibile, e dunque riconosciuto all'interno di un circuito che premia proprio la visibilità e la riconoscibilità.
E poco importa se oggi pubblicare è diventato nulla più che un tasto sulle principali piattaforme di produzione digitale. Perché l'idea della pubblicazione come forma di successo, e quella dello scrittore che ne deriva, sono più forti e radicate di questa evidenza.
L'ultima volta che mi hanno chiamato "scrittore" è capitato a cena con alcuni amici, quando la compagna di uno di loro s'è complimentata per il libro chiedendomi appunto, con una certa serietà, se da ora in poi avrebbe dovuto chiamarmi "scrittore". Ne è seguito un imbarazzato siparietto in cui cercavo di spiegare che no, non sono, o perlomeno non mi sento uno scrittore.
Una cosa non semplice da spiegare, dato che non esiste un'altra parola per identificare chi scrive e pubblica un libro.
E infatti, la mia amica mi ha prontamente domandato: "e allora, se non sei uno scrittore, ma hai pubblicato un libro, come devo chiamarti?"
Scrivente, se potessi usarla facilmente, sarebbe la parola che userei per descrivermi, perché ha in sé una sfumatura di ancora non compiuto che trovo perfettamente adeguata a descrivere chi, come me, scrive ma sente di non aver ancora raggiunto una completa padronanza della scrittura come mezzo espressivo.
A questo punto è probabile che più d'un lettore di questo post si stia chiedendo: "allora, caro mio, se non senti d'essere uno scrittore pur avendo scritto due libri, entrambi pubblicati da editori non a pagamento, che cosa, per te, rende tale uno scrittore?".
Ed è una domanda legittima di fronte a un imbarazzo che, a molti, potrebbe sembrare soltanto spocchia travestita da falsa modestia.
Il primo criterio che secondo me rende tale uno scrittore è un criterio economico. Uno scrittore è qualcuno a cui la scrittura paga le bollette e mette in tavola la pagnotta. Perché penso fortemente che la scrittura sia un lavoro e credo anche che lo scrittore debba essere conscio che questa sua capacità possa e debba essere, a volte, messa a disposizione di chi ne ha bisogno o di chi la richiede.
Naturalmente questo criterio economico, ne sono consapevole, è debole, confuso e attaccabile. Io stesso conosco diversi bravi scrittori che dalla scrittura non ricavano un soldo o almeno non ne ricavano abbastanza da potersi mantenere. Eppure non fatico a definirli scrittori.
Questo accade perché riconosco in loro almeno altri due aspetti che nella scrittura mi paiono fondamentali e irrinunciabili: la ricerca della costanza e la ricerca della tecnica.
La costanza è l'abitudine a scrivere sempre e indipendentemente dalla possibilità di essere pubblicati. Scrivere come esercizio quotidiano, come allenamento alla scrittura e come forma di produttività. È qualcosa che io fatico a permettermi e che per questo motivo rimpiango molto.
La tecnica invece è la riflessione sulla forma e sullo stile della propria scrittura. Il lavoro sulla lingua e il tuning della propria voce. Della tecnica fanno parte lo studio della punteggiatura e la lettura come dissezione della scrittura altrui.
La tecnica assume poi un aspetto ulteriore, per me che sono principalmente un web writer per passione e in parte per lavoro. Perché nel web la tecnica di scrittura non è solo forma e stile, lingua e voce. La scrittura digitale è anche formattazione e leggibilità, ottimizzazione e ipertestualità.
Tutto ciò si declina in una forma di testualità che è anche tipografica, non soltanto scritturale. Dove gli equilibri non sono soltanto tra le parole, ma tra diverse componenti del testo: dalle immagini ai mark up html che creano i diversi livelli di lettura, comprensione e uso del testo. Fino all'architettura complessiva della piattaforma che scegliamo di utilizzare, almeno quando ci è possibile intervenire direttamente su di essa.
Sostentamento, costanza e tecnica sono, ricapitolando, gli elementi che rendono tale uno scrittore. O, almeno, sono questi gli elementi dalla cui parziale mancanza si produce il mio imbarazzo nell'essere definito scrittore e la mia difficoltà nel definirmi tale.
Forse in questo mio imbarazzo c'è qualcosa di radicalmente sbagliato.
È una forma d'imbarazzo molto personale e privata e non andrebbe scambiata, come a volte è successo, per un tentativo d'imporre ad altri un pensiero e una visione delle cose che è solo mia.
Non mi interessa, qui, stabilire i criteri di una qualsivoglia ontologia dello scrittore. Piuttosto riflettere su certi automatismi del pensiero. Come quello che mi vuole scrittore grazie alla pubblicazione di un libro, cartaceo. Nonostante, a conti fatti, io scriva con una certa regolarità in rete e altrove da anni. Automatismi che sono altrettanti indicatori dei concetti con cui la cultura costruisce i nostri immaginari.
Ma forse, in questo mio imbarazzo profondo, c'è qualcosa di radicalmente sbagliato - spocchia travestita da falsa modestia, come dicevo più sopra - e a tutti gli effetti due libri pubblicati, senza l'ausilio di un grimaldello economico, mi rendono uno scrittore a tutti gli effetti. A dispetto del fatto che io, dalla scrittura, non ci ricavi abbastanza soldi da potermi comprare tutto il tempo necessario per scrivere, senza sottrarlo, come accade oggi, dal lavoro e dalla vita.
E forse dovrei arrendermi all'evidenza che le persone, anche quelle che mi sono vicine da tanto tempo, prenderanno a guardarmi e trattarmi in modo diverso da prima.
Come se una manciata di parole, stampate nero su bianco in un foglio di carta o formattate da un foglio di stile su uno schermo, avessero la qualità magica di rendermi più colto e intelligente e, allo stesso tempo, di smussare gli spigoli meno piacevoli del mio carattere: "è vero, sarà pure uno stronzo, egocentrico, saccente e spocchioso individuo; ma è pur sempre uno scrittore".
Mi chiedo se questi pensieri facciano parte dell'esperienza di altri? Persone che, come me, scelgono la scrittura come mezzo per provare a dare forma ai propri pensieri.
Come si resta coerenti a se stessi quando qualcosa che cade in un'alterità radicale interviene a modificare l'immagine che gli altri hanno di noi?
Come - in definitiva mi domando, e non ho ancora trovato risposta - si convive con questo stigma della scrittura?