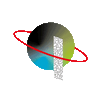I diari dello #skatemolotov: Porto Cervo
Cosa può significare una tavola da skate nel cuore di quella Disneyland sarda che è Porto Cervo. cristina Lunedì prova a raccontarlo ricordando i suoi trascorsi sullo skate tra la scoperta dello spazio e la ribellione ai luoghi.

La rivincita delle capre: note (auto)etnografiche sui nativi di Disneyland.
Alla signora Anna M.,
per la gioia provata a riprendere lo skate dopo vent’anni proprio sotto casa sua, in piena notte, in risposta alle angherie subite da tre generazioni di adolescenti a causa del suo isterico e vile esercizio di potere.
Sono nata e vissuta fino alla maggiore età a Porto Cervo, una delle all’epoca mille anime residenti in circa duemila ettari di costa nord-occidentale sarda. Il toponimo nasce agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, quando il principe ismaelita Karim Aga Khan IV acquista gran parte dei terreni della zona e vi installa una prestigiosa ed esclusiva Disneyland per le classi dominanti mondiali, la Costa Smeralda. Esattamente come il parco di divertimenti californiano, la Costa non identifica un’estensione geografica ma un format immobiliare, che congela lo spazio reale nella scenografia di un gioco, il gioco dell’uomo nella natura vergine, ad uso e consumo di pochi e facoltosi happy fews.
In quanto residenti, noi eravamo un paradosso: la nostra sola presenza insinuava un imbarazzante principio di realtà, di vita comune, negli scenari edenici delle vacanze miliardarie. Vivevamo nel lato B della Costa, negli interstizi di una rappresentazione che non ci prevedeva.
Ho iniziato ad andare in skate nel 1985, a otto anni, e ho continuato a farlo fino all’età del motorino, il 1991. Per me lo skate non è stato né uno sport, né propriamente uno stile di vita, ma piuttosto una ratio attraverso cui ho preso coscienza del mio corpo, fatto esperienza diretta dello spazio e stretto amicizie fondate su un sogno di emancipazione fisica e immaginaria cui aderivo con fiducia cieca e assoluta.

Il lato B di Disneyland: cartografare l’inferno
Per me e i miei fratelli, il primo luogo proprio sono state “le rocce”. Abitavamo in uno dei posti peggiori della zona, arroccata su un monte significativamente chiamato l’infarru, l’inferno, percorso da strade dissestate e ripidissime.
L’area di macchia dietro casa era il nostro territorio: le nostre attività si dividevano fra avanscoperta, alla ricerca di punti praticabili, e allestimento e cura delle “casette”, grotte poco profonde o semplici rientranze rocciose che per noi costituivano immediatamente un interno, punto di riparo e riferimento topografico. I nostri parenti ci chiamavano “le capre”, e per noi era un complimento. Per me, soprattutto, la capra era una specie di totem, modello agonistico e ideale di equità sociale: il fatto che tracciasse lo spazio sugli zoccoli, che potesse arrivare ovunque senza bisogno né di ali, né di forza, né di artigli, affidandosi al solo gioco di leve fra arti e roccia, ne faceva l’emblema stesso della libertà, una libertà tarata sul corpo di un bambino, in cui mi potevo identificare.
Lo skate univa la smania cartografica e la passione per i disequilibri al fatto di esercitarli su un terreno di appannaggio degli adulti, l’asfalto. Poter paragonare la mia velocità a quella di un’automobile – secondo te siamo veloci come una macchina? In questo punto secondo te siamo più veloci della macchina di mamma? E di quella di babbo?, erano le domande con cui ci ossessionavamo a vicenda io e mio fratello – mi faceva sentire non adulta, ma molto meglio, alla pari di un adulto, come se, da bambini e in quanto bambini, avessimo inventato in autonomia un modo di vivere attivamente lo spazio comparabile a quello dei grandi.
All’inizio stavo seduta, come su uno slittino, e quando mi spaventavo frenavo con le scarpe, distruggendole, e in casi estremi mi buttavo a sedere sull’asfalto, con esasperazione di mia madre che per punizione mi faceva andare in giro con due toppe alle ginocchia e una sulle chiappe. Da seduta facevo discese lunghe e molto ripide, a velocità altissime. Poi risalivo a piedi di pochi metri e affrontavo la breve rincorsa in posizione eretta, con i muscoli sciolti dalla prova del fuoco precedente e abbastanza sicura di me da azzardare le prime virate.

Dalla lotta alla danza: la Chiesa di Liscia di Vacca
La mia tecnica ha subito la svolta decisiva a Liscia di Vacca, piccolo insediamento di una ventina di famiglie sopra la Marina, a quattro chilometri da casa mia. Io miei genitori avevamo degli amici in quella zona e io e mio fratello avevamo iniziato a portarci dietro lo skate. La piazzetta antistante è un avvallamento concavo che circonda ad anello l’edificio. Un pool perfetto, e infatti i bambini e gli adolescenti della zona già ci giocavano.
Io non ero per niente agile. Non erano abituata a condividere lo spazio con degli sconosciuti, per giunta più grandi ed esperti di me. L’asfalto mi aveva abituata a ad esercitare molta forza sulla tavola, e anche se la pendenza era irrisoria rispetto a quelle che facevo di solito era come se mi mancasse il terreno sotto i piedi. Poi la soluzione è venuta da sé, guardando gli altri e sperimentando: piegare le gambe, combinare il perno col dosaggio di peso in verticale.
Usare il baricentro del mio corpo come un timone mi permetteva di reagire al pavimento liscio e senza direzioni della piazza in modo amabile, senza forzo. Mi vivevo quella scoperta, banale e ovvia per chiunque, come un qualcosa di miracoloso, come l’esperienza diretta, sul mio corpo, della reversibilità di un evento. Il rapporto con la velocità, la possibilità di trattenere, modulare, differire e re-orientare una spinta che fino a poco tempo prima mi vivevo come ineluttabile, è una delle sensazioni più appaganti che abbia mai provato: non quello che può fare un corpo ma quello che può non fare, la possibilità di non ubbidire a, di negoziare persino il principio di causalità per eccellenza, la forza di gravità.

Contro-utopie caprine: il Centro di Porto Cervo
Porto Cervo funziona come una specie di Terra di Utopia del capitale, rovescio mitico del sogno di ogni possidente all’esclusività dello spazio: la morfologia irregolare della costa, il camouflage architettonico, la distribuzione rada e dislocata delle abitazioni, servono tutti a far sentire ognuno dei proprietari o affittuari come se fosse solo al mondo, il primo uomo a beneficiare del paradiso terrestre. In centro la funzione topologica è presa in carico dai prezzi e dalle guardie giurate, che sostituiscono le barriere naturali con sbarre silenziose che ne fanno un posto comunque inaccessibile, solo da guardare, possibilmente in silenzio.
D’inverno era praticamente deserto, e quasi tutti gli adolescenti della zona (cioè una ventina) ci andavano in skate. I portocervini erano bravissimi e avevano tavole da sogno, larghe la metà e pesanti un quarto delle nostre (io per tutta la prima media ho fatto i compiti di italiano a Stefano V. in cambio di due ore della sua lingua nera in fibra di carbonio, che alla fine mi ha regalato). Per noi lo skate era un mezzo di trasporto, o meglio la tavola faceva dello spazio stesso il partner di uno spostamento, ce lo faceva scrivere dal nostro punto di vista, come “le rocce”.
Quel principio motore semplicissimo e perfetto, di eleganza caprina, era sufficiente a disegnare una carta che non era la negazione del padronato consortile ma la sua contro-utopia, perché rendeva quegli stessi spazi un bene partecipabile, un potenziale a disposizione di chiunque fosse disposto a sposarne le determinazioni. Ancora oggi, penso allo skate prima di tutto come a un principio di espropriazione, come se attivasse una specie di relazione letterale con il mondo, materica, danza fra gravi simmetrica e reversibile che ne azzera il capitale di simboli. Lo spazio tende a reificare i valori di chi lo scrive, che diventano assoluti e incontrovertibili fino a prova contraria. Ecco, lo skate è stato la mia prova contraria.